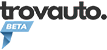Se si vuole estendere l’utilizzo dell’energia elettrica su più fronti - dai veicoli alle case -, sostituendo progressivamente le fonti non rinnovabili, è essenziale disporre di una rete non solo in grado di coprire in modo capillare tutto il territorio nazionale, ma anche di soddisfare le previsioni di crescita del fabbisogno energetico. Il riferimento è in primo luogo alla domanda derivante dall'incremento del parco circolante di auto elettriche, ma anche a quella legata alla maggiore diffusione di attività energivore, dall'uso dell'intelligenza artificiale alle applicazioni informatiche come cloud, blockchain e data center. L’elemento più visibile di questa grande trasformazione, e quello che più ci interessa in questa sede, è ovviamente rappresentato dalla disponibilità di colonnine di ricarica per le vetture a corrente.
La situazione in Europa è quanto mai eterogenea, con differenze marcate in tema sia di parco circolante delle Bev sia di numero delle colonnine. Se sotto questo profilo i Paesi Bassi svettano ‒ addirittura in senso assoluto quanto ai punti di ricarica ‒, anche grazie a incentivi statali particolarmente generosi, al pari di altre nazioni del Nord Europa, anche Germania e Francia stanno recuperando terreno, soprattutto per quanto riguarda le installazioni di colonnine. In numeri assoluti, l’Italia resta lontana dai leader continentali, ma bisogna pure tenere conto dell'incidenza delle auto elettriche sul totale del parco circolante: un valore che, al momento, vede il nostro Paese ancora nelle parti basse della classifica. Qualcosa, comunque, sta cambiando anche dalle nostre parti: secondo i dati diffusi da Motus-E, l'associazione degli operatori del settore, nel corso del primo semestre di quest'anno sono stati installati 8.438 nuovi punti di ricarica a uso pubblico, con una crescita dell’80% rispetto ai primi sei mesi del 2022. Le colonnine sono quindi arrivate a quota 45.210, ma, indipendentemente dal loro numero, resta un problema di qualità: la stragrande maggioranza (39.759), infatti, è del tipo a corrente alternata con potenza fino a 43 kW, mentre le rimanenti sono suddivise tra quelle fra 44 e 99 kW (2.233) e quelle superiori a 100 kW (3.045). In netto progresso, in compenso, la situazione sulla rete autostradale, che fino a poco fa arrancava: oggi un quarto delle aree di servizio è dotato di punti di ricarica, per un totale di 657, il 77% dei quali ha una potenza superiore a 43 kW, con il 58% che supera i 150.
VA MEGLIO IN AUTOSTRADA

La distribuzione di punti di ricarica nella nostra rete autostradale sta migliorando, anche se non tutte le società di gestione si dimostrano parimenti sensibili alle esigenze degli utilizzatori di veicoli elettrici.
Se analizziamo la distribuzione delle colonnine, oltre il 99% del territorio italiano ne dispone di almeno una nel raggio di 20 chilometri e l’86% in uno di dieci: numeri abbastanza rassicuranti e decisamente migliori rispetto a quanto richiesto ai Paesi membri dell'Unione Europea dalla normativa Dafi (Directive alternative fuel initiative), che impone l’installazione di un impianto ogni 60 chilometri. Sulla carta, dunque, i punti di ricarica in Italia sono più che sufficienti in rapporto alle elettriche circolanti: la cosa, tuttavia, si spiega anche con l'ancora scarsa diffusione di queste ultime. C'è, poi, un altro aspetto critico molto importante: secondo l'Unrae, l'associazione dei costruttori stranieri, più del 20% delle colonnine installate risulta ancora non utilizzabile, a causa del mancato allacciamento alla rete da parte del distributore di energia o per altri motivi burocratici.
Non si può negare, inoltre, la permanenza di un forte squilibrio geografico nella distribuzione dei punti di ricarica, dato che circa il 56% delle infrastrutture è localizzato nel Nord, il 21% al Centro e il 23% al Sud (isole comprese). Passando alle singole regioni, la classifica è guidata dalla Lombardia con 7.657 colonnine, davanti a Piemonte (4.514), Veneto (4.420), Lazio (4.351) ed Emilia-Romagna (3.966). All'estremo opposto si trovano, invece, Molise (188) e Basilicata (270).
CRESCITA DISOMOGENEA
Per alimentare le colonnine, però, serve energia e sempre più ne servirà, coerentemente con i macro-trend globali e con il Piano di sviluppo 2023 redatto dal gruppo Terna (proprietario del network di trasmissione italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione). La rete nazionale conta oggi oltre 75 mila chilometri di linee per l’alta tensione e centinaia di stazioni di trasformazione, ma nei prossimi dieci anni sono previsti 21 miliardi di euro d'investimenti per accelerare la transizione energetica, favorire la decarbonizzazione, ridurre la dipendenza dalle fonti di approvvigionamento straniere e rendere il sistema elettrico sempre più sostenibile sotto il profilo ambientale. Non solo: è fondamentale ammodernare la rete di distribuzione, per evitare sovraccarichi e rischi di black-out, che già si verificano d'estate nelle grandi città per il semplice utilizzo intensivo degli impianti di climatizzazione. Le infrastrutture di metropoli come Milano e Roma, del resto, risultano ormai datate, frutto come sono di storici passaggi tra differenti società di gestione.
Uno dei progetti più importanti, infine, è quello della rete detta Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell’energia in corrente continua attraverso la realizzazione di cinque nuove dorsali elettriche, in aggiunta al Tyrrhenian Link e all’Adriatic Link; queste ultime costituiscono due opere di assoluto valore, con la prima che, con i suoi 1.000 MW, rappresenta il più importante progetto mondiale per la trasmissione di energia elettrica attraverso cavi sottomarini. Si tratta di un imponente ammodernamento degli elettrodotti che consentirà di trasferire sempre più potenza generata da fonti rinnovabili del Sud verso le regioni del Nord affamate di energia. Pensate per ottimizzare il surplus di produzione del Mezzogiorno e del Centro Italia sono anche le linee Montalto-Milano, la Central Link, la Dorsale Sarda, quella Ionica-Tirrenica e l'Adriatica, che metterà in comunicazione il Nord della Puglia, caratterizzato da un'alta produzione di energia eolica, con l’Emilia-Romagna. L'Italia, del resto, intende diventare un hub elettrico europeo, rafforzando le interconnessioni con le reti straniere per integrare in modo più efficiente le energie rinnovabili: ne sono esempi il ponte energetico sottomarino da 600 MW che la collega alla Tunisia e quello con la Grecia (200 km, 500 MW), in grado di raddoppiare la capacità di scambio tra i due Paesi.

Avanti adagio con il Pnrr
Una fetta importante del Piano nazionale di ripresa e resilienza riguarda proprio la rete di colonnine pubbliche. Si tratta di 713 milioni di euro che la UE ci ha destinato con uno scopo preciso: aumentare la quantità e la qualità dei punti di ricarica. Contributi che andranno a coprire il 40% delle spese degli operatori che installano le infrastrutture, con distinguo importanti riguardo alla loro localizzazione: quasi il 65% delle colonnine dovrà infatti essere situato all’interno delle aree urbane e avere una potenza di almeno 90 kW, quando oggi la maggior parte di quelle esistenti non supera i 22. Dei 21.255 punti di ricarica previsti dal Pnrr, 7.500 dovranno invece essere collocati sulle strade extraurbane e avere una potenza di almeno 175 kW (saranno di tipo ultrafast, quindi). Al giugno scorso, in Italia si contavano 24.942 infrastrutture, in 16.537 location, per un totale di 45.210 punti di ricarica; secondo le previsioni del governo, però, questi ultimi, dovranno diventare almeno 110 mila entro il 2030. I fondi del Pnrr hanno dovuto sottostare a un iter burocratico durato quasi due anni e solo il 20 maggio scorso, a meno di un mese dalla scadenza per le richieste, sono stati emanati i primi bandi per l’assegnazione, non senza difficoltà a causa dei molti vincoli imposti dal decreto che regolava le assegnazioni. Limiti che dovranno essere corretti dall'attuale esecutivo in tempo per rendere più efficace la seconda tranche di assegnazione di risorse, alla quale l'Italia non può rinunciare.
COMMENTI([NUM]) NESSUN COMMENTO
Per eventuali chiarimenti la preghiamo di contattarci all'indirizzo web@edidomus.it