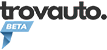Per noi europei, il nuovo mondo è sempre là, dall’altra parte dell’oceano. Arrivare in Indiana per la prima Indy500 (che ricordavamo ancora come “500 Miglia di Indianapolis”) è davvero un viaggio verso qualcosa di esotico più che di nuovo. Il circuito ovale - prima anomalia rispetto ai più rassicuranti e agili tracciati della F1 - è a Speedway, una piccola cittadina a poche miglia da Indianapolis, nata e sviluppata intorno all’autodromo e talmente legata alla sua mole protettiva da essere stata battezzata con il sostantivo che indica, appunto, una pista.
A tutto gas (per tutta la gara). Lo sviluppo del tracciato è di 4 chilometri, formato da quattro rettilinei, due corti e due lunghi, uniti da altrettante curve, sopraelevate con un’inclinazione di 9 gradi: un percorso tanto monotono e ipnotico da non richiedere una particolare abilità, pensiamo noi, se non quella di non addormentarsi nelle tre ore e passa di gara. Poi scopriamo che la velocità media di percorrenza è di oltre 370 km/h - media! - e che le auto sono sempre guidate al massimo, nel senso che il pilota non molla mai. Un ritmo di gara che ci viene confermato dalla prima ripresa on-board che ci restituisce il rumore del motore: costante, senza una flessione del numero di giri, un alleggerimento del gas, niente, sempre a manetta. È per questo che tutta l’attenzione va al pilota, unica e vera star in una tecnologia che offre a tutti le stesse possibilità di successo perché uniformata nelle prestazioni: telaio unico, quello sicuro e performante disegnato e prodotto da Dallara, e un motore da scegliere tra Chevrolet e Honda, entrambi 6 cilindri biturbo da 700 CV. Il resto è strategia, sangue freddo, resistenza e lucidità. Tutte doti che le 350 mila persone (che fanno di Indy500 lo spettacolo sportivo più seguito in presenza al mondo) colgono e interiorizzano, riversando un entusiasmo sconfinato sulla squadra di 33 gladiatori che si sfidano in pista, tutti assolutamente disponibili ad incontrare la gente, a sottoporsi a lunghe e a volte estenuanti sessioni di autografi, ad essere i soggetti di selfie improvvisati. Perché - questa è la regola principale e non scritta - loro sono al servizio di chi li va a vedere, di chi paga il biglietto, un rispetto ricambiato con un tifo da stadio. Inutile dire come un’invasione del genere stravolga la quieta e quotidiana colonna sonora della città a partire dal giovedì antecedente.
Parata di mostri. Ci pensano i potenti e smarmittati V8 montati su mostruosi pick-up e muscle-car apocalittiche (soprattutto Challenger e Mustang, con una prevalenza delle prime) oltre ai non meno rumorosi bicilindrici Harley-Davidson. La città abbozza, si riempie di bandiere a scacchi - il motivo grafico predominante con cui viene ricoperta qualsiasi cosa, idranti compresi - ed è tutto un “Welcome Race Fans!”. Nei giorni della corsa, che in America identificano semplicemente come “the Race”, circuito e dintorni assumono identità a metà tra Woodstock, per lo Snake Pit che vede sul palco allestito alla curva 3 la performance di dj e musicisti tecno presentata dal wrestler Titus O’Neil, e la 24 Ore di Le Mans, per la notte brava dei tifosi nei campeggi circostanti affollati dai siluri in acciaio delle Streamliner, le roulotte più iconiche degli States, e da autobus a due piani che si ostinano a chiamare camper.
That's Indianapolis. E poi arriva la domenica, una giornata lunghissima. Parte alle 5 del mattino, con il colpo di cannone che annuncia l’apertura dei cancelli dello Speedway, e continua alle 8, con la messa celebrata dal cappellano della Indy500 che indossa la stola a scacchi e, davanti al box trasformato in chiesa, ha parcheggiato “la macchina del preste”, una monoposto IndyCar rossa, con tanto di croce ricamata sul poggiatesta. Mentre la gente inizia a fluire e a riempire paddock e tribune, una passeggiata con Giampaolo Dallara tra le auto già schierate si trasforma in un’esperienza surreale. Lo salutano tutti, addetti ai lavori e semplici spettatori, leggende del motorsport, come Mario Andretti e Roger Penske, ma anche piloti, come il brasiliano Tony Kanaan, che ha guidato sempre e solo macchine Dallara. Salutano con un rispetto e una cordialità alle quali Dallara risponde con la semplicità del grande uomo, come a voler sottolineare che non è il caso di essere ossequiosi, che se lo sapessero fare, l’inviterebbe volentieri a giocare a scopone dopo la gara. Nel frattempo la pista si accende con la celebrazione del Memorial Day, la festa nazionale dedicata ai caduti in tutte le guerre, con cadetti, sfilate, marce e la cultura del rispetto ai militari tipica americana. Nel silenzio più totale risuona l’inno nazionale, tutti in piedi, mano sul cuore e la pattuglia acrobatica che arriva al termine dell’acuto finale, sorvolando in formazione il rettilineo a bassa quota: “That’s America, that’s Indianapolis” viene da pensare. Nel frastuono di 33 motori accesi dalla frase “Drivers, start your engines” (fino al 2016 la formula diceva “gentlemen” ma poi si è adeguata al rispetto di genere) con le procedure di partenza la corsa ha inizio. I sorpassi si moltiplicano, le macchine che finiscono a muro anche, nella corsia box impazza il carosello dei cambi gomme e dei rifornimenti, fatti con quella miscela metanolo-benzina (85-15) che era tanto trasparente da aver richiesto un’aggiunta di gomma per renderla visibile ai meccanici. Con le posizioni incerte fino alla fine, negli ultimi due giri dei 200 totali a spuntarla è lo svedese Marcus Ericcson, che si aggiudica la 106esima Indy500. Nel suo ufficio in pista, Giampaolo Dallara esulta e commenta, come un qualsiasi appassionato, sempre stupito da quello che succede. È in questa curiosità di fondo, che guarda ciò che avviene con l'umiltà di chi pensa di avere sempre qualcosa da imparare che ha radice il suo successo americano, che ha portato tecnologia e innovazione in una serie dove c’era fame di prestazioni ma anche di sicurezza. Missione compiuta, Ingegnere.
COMMENTI([NUM]) NESSUN COMMENTO
Per eventuali chiarimenti la preghiamo di contattarci all'indirizzo web@edidomus.it
.png)